testi anni 70
“André Kertész”, a cura di Nicolas Ducrot Stè Nlle des Editions du Chène (Parigi 1972) – “August Sander, Menschen Ohne Maske (Uomini senza maschera)”, autobiografia a cura di Gunther Sander e introduzione di Golo Mann. Editrice C.J. BUcher-Luzern und Frankfurt/M, in “Foto Zoom”, maggio 1973

Kertész e Sander, di cui le monografie citate — entrambe ottimamente stampate e redatte con un’impaginazione priva di enfasi — ci offrono una panoramica completa… possiamo considerarli autori paralleli e divergenti. Paralleli perché entrambi massimamente attivi nel periodo tra le due guerre (1920-1940) ed entrambi inseriti nel fermento culturale che fece di Parigi e Weimar gli estremi bagliori prima che la notte nazista scendesse sull’Europa. Divergenti perché radicalmente opposte le ragioni che li portavano a produrre fotografie. Sander è un fotografo ritrattista per educazione professionale; in lui non c’è indulgenza «creativa» ma solo rigore e umiltà di artigiano, prima dipendente e poi titolare di un classico atelier con sala di posa (a Linz e a Colonia). Dei suoi due figli, Gunther — autore delle note biografiche del volume — ed Erich è costui, il maggiore, che operando nel Partito Comunista Tedesco tra il 1925 ed il 1930 mette il padre di fronte a un dilemma drammatico: la necessità di riaffermare anche attraverso un personale atto di coraggio civile la propria opposizione alla dittatura. Contemporaneamente sono i pittori Dix e Kandinsky — che portavano a Sander i quadri da riprodurre — a incanalarne l’impegno verso l’opera di documentazione antropologica, che resterà probabilmente la maggiore condotta da un singolo fotografo in Europa. La raccolta di ritratti sotto l’insegna generica di «Uomini del Ventesimo Secolo» copre gli anni dal 1925 al 1955 circa (Sander è nato nel 1876 e muore a Colonia nel 1964). Sono persone o gruppi, in sala di posa ma più spesso all’esterno, in città o in campagna. A media distanza (tutta la persona o il busto), con luce diffusa, grande formato di ripresa con fondo riconoscibile anche se flou, sguardo «cosciente» nell’obiettivo. Gli oggetti impugnati, i vestiti, i cani, i dati precisi del decor personale o i frammenti di ambiente… compongono una memorabile fisionomia collettiva della Germania. Autocoscienza, sicurezza, formalismo, conformismo, tristezza sono i connotati più frequenti, assieme all’invisibile presenza di un rapporto «di fiducia» col fotografo. Quel che stupisce è appunto la capacità di Sander di equilibrare sotto il proprio dominio ogni soggetto, entro una prospettiva di estrema esattezza documentaria. Sander non giudica inquadrando o deformando, o bloccando un attimo fuggevole; ma fa giudicare il soggetto da sé, lasciando che egli operi un’inconscia autopresentazione, cioè che esprima il suo «ruolo». Il che, soprattutto per la borghesia, gli intellettuali, i militari, i burocrati… porta a risultati visivi di allucinante eloquenza. La Gestapo nel 1934 sequestra e distrugge il primo libro di Sander «Volto del tempo» svelando con questa persecuzione il fondo di ottusa prepotenza del regime, anche sul terreno dell’immagine. Dal 1936 al 1945 August Sander fa praticamente soltanto dei paesaggi, aiutato da Erich costretto alla clandestinità (dopo l’inizio della guerra verrà ucciso dalle SS). Anche molti dei negativi di Sander vengono distrutti, ma egli ne ha già prudentemente stampate delle copie perfette, messe in salvo in un villaggio di montagna. Solo nel dopoguerra — con la prima Photokina del 1950 e con la visita di Steichen che nel ’53 sta preparando «La famiglia dell’uomo» — il lavoro di Sander viene scoperto e divulgato nella sua ampiezza. Più rigoroso di Paul Strand, più organico e meno «casual» di Eugene Atget (a questi due autori possiamo collegarlo sul piano «stilistico»), Sander ha lavorato con umiltà di testimone sensibile a una mirabile «opera aperta» che gli anni venturi arricchiranno ancora di significato e di valori.
All’opposto Andre Kertész è il prototipo del fotoamatore con ambizioni da artista, del curioso instancabile; disimpegnato da ogni ragione storica, sperimentatore di tecniche soggettive, estraneo a ogni vincolo professionale e a ogni rapporto subalterno con la committenza.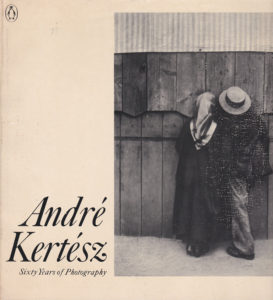 Giunto ora alla vecchiaia, confortato da amicizie autorevoli, ricondotto a una dimensione culturale europea dopo gli anni di permanenza negli Stati Uniti, eccolo produrre la monografia riassuntiva, curata da Nicolas Ducrot. Ci sembra che le immagini migliori siano quelle iniziali che ci restituiscono la patria di Kertész, l’Ungheria dei villaggi assonnati, suonatori ambulanti, innamorati, soldati travolti dalla sconfitta dell’Impero o eccitati nella breve stagione rivoluzionaria del 1919. Kertész scopre il mezzo e conosce il suo ambiente; si muove con naturalezza, come Gegé Primoli nella Roma umbertina o Francesco Negri a Casale Monferrato. Poi Parigi, dal 1925 e per tutti gli anni trenta. I vicoli di Montmartre con cavalli e biciclette visti dall’alto, ponti e giardini con inquadrature diagonali, senza quell’analisi umana che invece stava conducendo proprio il suo connazionale Brassaï, e che Cartier-Bresson avrebbe continuato negli anni seguenti «a la sauvette». E insieme ritratti adulatori agli artisti Chagall e Eisenstein, e strani nudi femminili deformati da specchi curvi, sotto la spinta e gli insegnamenti «surreali» del più deplorevole Man Ray. Più tardi l’approdo negli Stati Uniti e la scoperta attonita dei grattacieli a Manhattan. La parabola sembra concludersi con altri viaggi in Europa nel dopoguerra, tra cui uno in Ungheria nel 1965, in occasione della sua personale a Budapest. Come è capitato a Lartigue (e anche a ben più complesse personalità, come Edward Steichen) gli anni dell’anzianità corrispondono a un ripiegamento su un microcosmo familiare; angoli della propria casa, ritratti alla moglie e ad amici in vacanza, sguardi assonnati alla propria intimità. Kertész ormai placato si guarda indietro; non ha avuto bisogno di nessuno, probabilmente non ha mai lavorato per vivere, ha posato intorno a sé sguardi di scetticismo, di ironica rigidità. E adesso che ha la monografia?
Giunto ora alla vecchiaia, confortato da amicizie autorevoli, ricondotto a una dimensione culturale europea dopo gli anni di permanenza negli Stati Uniti, eccolo produrre la monografia riassuntiva, curata da Nicolas Ducrot. Ci sembra che le immagini migliori siano quelle iniziali che ci restituiscono la patria di Kertész, l’Ungheria dei villaggi assonnati, suonatori ambulanti, innamorati, soldati travolti dalla sconfitta dell’Impero o eccitati nella breve stagione rivoluzionaria del 1919. Kertész scopre il mezzo e conosce il suo ambiente; si muove con naturalezza, come Gegé Primoli nella Roma umbertina o Francesco Negri a Casale Monferrato. Poi Parigi, dal 1925 e per tutti gli anni trenta. I vicoli di Montmartre con cavalli e biciclette visti dall’alto, ponti e giardini con inquadrature diagonali, senza quell’analisi umana che invece stava conducendo proprio il suo connazionale Brassaï, e che Cartier-Bresson avrebbe continuato negli anni seguenti «a la sauvette». E insieme ritratti adulatori agli artisti Chagall e Eisenstein, e strani nudi femminili deformati da specchi curvi, sotto la spinta e gli insegnamenti «surreali» del più deplorevole Man Ray. Più tardi l’approdo negli Stati Uniti e la scoperta attonita dei grattacieli a Manhattan. La parabola sembra concludersi con altri viaggi in Europa nel dopoguerra, tra cui uno in Ungheria nel 1965, in occasione della sua personale a Budapest. Come è capitato a Lartigue (e anche a ben più complesse personalità, come Edward Steichen) gli anni dell’anzianità corrispondono a un ripiegamento su un microcosmo familiare; angoli della propria casa, ritratti alla moglie e ad amici in vacanza, sguardi assonnati alla propria intimità. Kertész ormai placato si guarda indietro; non ha avuto bisogno di nessuno, probabilmente non ha mai lavorato per vivere, ha posato intorno a sé sguardi di scetticismo, di ironica rigidità. E adesso che ha la monografia?
.
di Bertolt Brecht ( Einaudi, 1972)
 Ad una serie di illustrazioni fotografiche, ritagliate dai settimanali americani o nordeuropei degli anni del conflitto, Brecht unisce rapidi epigrammi, come contrappunti di interpretazione storica e ideologica. L’operazione ha un duplice rischio: quello di annullare l’evidenza «ottica» delle fotografie scelte (cioè farle scomparire come testimonianza strutturale di determinati episodi o personaggi) e quello di fare diventare ogni soggetto un Simbolo, dimenticandone l’interna complessità. Questi rischi sono quasi totalmente superati dalla forza poetica delle sdegnate invettive di Brecht: l’immagine ottica si riduce a pretesto, minimale punto di partenza per la riaffermazione di giudizi che hanno tutta la nostra adesione. Tipici sono i versi sotto l’istantanea dell’incontro Goering-Goebbels, sotto le famose istantanee di Capa dello sbarco in Normandia e dei soldati USA in Sicilia, infine sotto il desolato mucchio di elmetti tedeschi capovolti in uno stagno («Non quando alla fine ce li hanno buttati in terra, fu l’ora della nostra amara disfatta. Fu quando obbedimmo, e li mettemmo in testa »). La fotografia non è concepita qui come linguaggio dotato di autonoma potenza comunicativa: è un’occhiata-pretesto per far partire da un concreto terreno gli epigrammi più amari, più sintetici, più esclusivi. Brecht conduce in altri termini un lavoro simile a quello del suo amico (e compagno) John Heartfield, non dimenticato autore di fotomontaggi antinazisti. Il collage veniva costruito da Heartfield con diversi brandelli ottici accostati su un solo foglio e offerti per un’immediata decifrazione «muta», cioè senza riferimenti letterari. Brecht lega una foto alla seguente con parole in versi e ottiene un’arma nuova, che colpisce simultaneamente su due traiettorie: l’occhio e la memoria-cultura del lettore.
Ad una serie di illustrazioni fotografiche, ritagliate dai settimanali americani o nordeuropei degli anni del conflitto, Brecht unisce rapidi epigrammi, come contrappunti di interpretazione storica e ideologica. L’operazione ha un duplice rischio: quello di annullare l’evidenza «ottica» delle fotografie scelte (cioè farle scomparire come testimonianza strutturale di determinati episodi o personaggi) e quello di fare diventare ogni soggetto un Simbolo, dimenticandone l’interna complessità. Questi rischi sono quasi totalmente superati dalla forza poetica delle sdegnate invettive di Brecht: l’immagine ottica si riduce a pretesto, minimale punto di partenza per la riaffermazione di giudizi che hanno tutta la nostra adesione. Tipici sono i versi sotto l’istantanea dell’incontro Goering-Goebbels, sotto le famose istantanee di Capa dello sbarco in Normandia e dei soldati USA in Sicilia, infine sotto il desolato mucchio di elmetti tedeschi capovolti in uno stagno («Non quando alla fine ce li hanno buttati in terra, fu l’ora della nostra amara disfatta. Fu quando obbedimmo, e li mettemmo in testa »). La fotografia non è concepita qui come linguaggio dotato di autonoma potenza comunicativa: è un’occhiata-pretesto per far partire da un concreto terreno gli epigrammi più amari, più sintetici, più esclusivi. Brecht conduce in altri termini un lavoro simile a quello del suo amico (e compagno) John Heartfield, non dimenticato autore di fotomontaggi antinazisti. Il collage veniva costruito da Heartfield con diversi brandelli ottici accostati su un solo foglio e offerti per un’immediata decifrazione «muta», cioè senza riferimenti letterari. Brecht lega una foto alla seguente con parole in versi e ottiene un’arma nuova, che colpisce simultaneamente su due traiettorie: l’occhio e la memoria-cultura del lettore.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
